Articolo originariamente pubblicato sul sito Letture.org
Dott. Sergio Bontempelli, Lei è autore del libro I rom. Una storia edito da Carocci: quali stereotipi caratterizzano la percezione, da parte dell’opinione pubblica italiana, delle minoranze romanes e quali dinamiche essi alimentano?
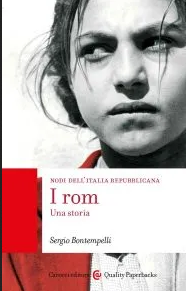 Direi che il principale stereotipo è quello dell’arretratezza: coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dei rom e dei sinti pensano spesso di incontrare popolazioni che, vivendo isolate dal corpo sociale, hanno preservato culture, modi di vivere, mentalità e tradizioni di un passato ormai scomparso. In fondo quando si parla di “nomadi” si pensa proprio a questo: a un mondo arcaico, forse addirittura primitivo (erano “nomadi” i cacciatori-raccoglitori della preistoria…), in ogni caso rimasto ai margini della modernità.
Direi che il principale stereotipo è quello dell’arretratezza: coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo dei rom e dei sinti pensano spesso di incontrare popolazioni che, vivendo isolate dal corpo sociale, hanno preservato culture, modi di vivere, mentalità e tradizioni di un passato ormai scomparso. In fondo quando si parla di “nomadi” si pensa proprio a questo: a un mondo arcaico, forse addirittura primitivo (erano “nomadi” i cacciatori-raccoglitori della preistoria…), in ogni caso rimasto ai margini della modernità.
Dico questo pensando anche alla mia esperienza personale. Mi capita spesso di essere contattato da fotografi, antropologi o giornalisti che mi chiedono di incontrare i rom, di fare una visita in qualche campo della mia città. E quasi sempre questa richiesta ne veicola un’altra, che in un primo momento rimane sotto traccia ma che non tarda poi a essere esplicitata: mi si chiede di poter assistere a qualche evento “rituale”, ad esempio a un matrimonio, a un battesimo, a una festa “tipica” o “tradizionale”. Il sottinteso è che i rom e i sinti, in quanto popolazioni arcaiche, abbiano da offrire qualche spettacolo esotico: che, insomma, incontrare i rom significhi fare un viaggio in un mondo misterioso, orientaleggiante, quasi magico. Questa idea sembrerebbe veicolare un’immagine romantica e positiva dei rom, ma si converte facilmente in una forma di stigmatizzazione: un gruppo rimasto ad uno stadio primitivo, per quanto affascinante possa apparire a un primo sguardo, sarà pur sempre caratterizzato da pratiche – per l’appunto – primitive, e quindi ad esempio da una mentalità patriarcale e misogina, o da un’organizzazione in clan familiari chiusi e violenti. Insomma, è come se si immaginasse una sorta di “sfasatura temporale”: mentre “noi” ci saremmo evoluti diventando moderni (e poi contemporanei e post-moderni), i rom sarebbero rimasti “indietro”, ancorati a culture del passato.
Nel mio testo cerco di mostrare in primo luogo che questa idea è del tutto sbagliata: i rom e i sinti non sono un corpo estraneo, ma fanno parte a pieno titolo della società italiana; vivono nel presente, nel nostro stesso mondo, contribuiscono ogni giorno a plasmarlo e ne sono a loro volta influenzati e condizionati. Ma c’è di più. Quel che cerco di mostrare nel libro è che questa immagine “esotica” dei rom e dei sinti è essa stessa il prodotto di una storia, perché nasce dalle politiche di segregazione e di discriminazione messe in atto prima dal regime fascista, e poi – ovviamente in modo molto diverso – dalla Repubblica italiana negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.
Cosa significa vivere da rom in Italia?
È difficile generalizzare, perché nel nostro paese i gruppi rom e sinti sono molti, e molto diversi tra loro. Uno dei tratti che li accomunano è sicuramente il fatto di subire una forte stigmatizzazione. Ad esempio, un giovane rom fatica a trovare un lavoro, perché nella percezione comune – che è anche la percezione di molti imprenditori – gli “zingari” sono pigri, fannulloni e imbroglioni, dunque non sono in grado di lavorare. O, ancora, una famiglia rom avrà più difficoltà di altre a trovare una casa in affitto: come segnalano ormai da decenni i report delle organizzazioni per i diritti umani, i proprietari privati si rifiutano spesso di firmare contratti di locazione con famiglie “zingare”, a prescindere dalla loro condizione economica. Anche quando riescono ad accedere al mercato dell’alloggio, i rom – ma la stessa cosa accade anche a molti stranieri – sono esposti a quella che si chiama discriminatory charge, cioè a un canone di affitto irragionevolmente più alto rispetto a quello richiesto ad altri inquilini.
Ancora più drammatiche sono le forme di discriminazione che subiscono i bambini rom, ad esempio nelle scuole: un bambino o una bambina etichettati come “zingari” sono guardati con sospetto e diffidenza dai loro compagni di classe, dal gruppo dei genitori, e a volte anche dagli insegnanti. Alcuni anni fa, un documento del Governo italiano denunciava ad esempio un «uso improprio del sostegno come strategia didattica»: in altre parole, il bambino rom in classe è percepito spesso come un bambino “problematico”, per cui si rende necessaria la presenza dell’insegnante di sostegno. E sempre lo stesso documento del Governo parlava di altissime percentuali di alunni rom (attorno al 30-40% del totale) certificati come portatori di handicap. Come se essere rom fosse, appunto, un handicap, una mancanza, un “problema”.
Questo è il quadro generale, ma non vanno trascurate le differenze. Chi abita di un alloggio ordinario – sia esso un appartamento in affitto, un’abitazione privata o una casa popolare – può occultare più facilmente le proprie origini rom, e dunque può difendersi meglio da queste forme di discriminazione (il che, sia chiaro, non è una bella cosa: significa che per avere dei diritti si è costretti a celare la propria identità, la propria appartenenza a un gruppo). Per chi invece vive in un “campo nomadi” le cose sono molto più difficili, perché in quel caso è impossibile nascondersi: quando il datore di lavoro vuole assumerti e ti chiede la carta di identità, vede subito dove abiti, e ti identifica immediatamente come “zingaro”… e la stessa cosa accade quando cerchi una casa, quando iscrivi il tuo bambino o la tua bambina a scuola, e così via.
Poi ci sono altre differenze rilevanti: non è la stessa cosa essere un rom italiano o un rom straniero, abitare in un campo regolare o in un insediamento “informale” (cioè in terreno considerato “abusivo”), avere il permesso di soggiorno o non averlo, essere cittadino di un paese europeo o un immigrato extra-UE. Questi diversi status condizionano in modo significativo le traiettorie di vita dei rom in Italia.
Qual è lo scenario delle minoranze romanes in Italia?
Quando parliamo di rom, ci immaginiamo di avere a che fare con una comunità compatta, fortemente coesa, con un insieme di tratti culturali ben definiti e univoci. Nulla di più sbagliato: l’universo dei rom è stato definito giustamente “un mondo di mondi”, o anche “una galassia di minoranze”. Si tratta cioè di un insieme molto variegato di gruppi, che hanno ben poco in comune tra loro. Ci sono anzitutto rilevanti differenze linguistiche: non tutti i rom e i sinti parlano il romanes, l’antica lingua di derivazione indiana che viene considerata spesso il tratto unificante di queste popolazioni (e che non va confuso con il rumeno, lingua neolatina molto lontana dagli idiomi dei rom). Anche tra coloro che parlano romanes ci sono differenze molto importanti, perché – solo per fare qualche esempio – il romanes parlato in Romania è molto diverso dai dialetti dei sinti italiani, o da quelli dei rom abruzzesi…
Parliamo poi di una pluralità che non è esclusivamente “etnica”, che cioè non riguarda solo le differenze linguistiche e culturali. La pluralità va intesa in senso più radicale, come pluralità di status economici, di ricchezza, di riconoscimento sociale, e ancora di mestieri, di appartenenze religiose, di cittadinanza, di origine geografica ecc.
Infine, un elemento importante che differenzia i vari gruppi è la condizione abitativa. Nella loro stragrande maggioranza, i rom e i sinti abitano in alloggi convenzionali: eppure la percezione comune – soprattutto nel Nord e nel Centro Italia – identifica i rom con i “campi nomadi”, al punto che lo stesso termine “rom” è divenuto quasi un sinonimo di “abitante dei campi”. E invece le cose non stanno così: non solo la maggioranza dei rom abita in casa, ma vi sono – all’inverso – molte famiglie non-rom che per i motivi più vari sono finite ad abitare nei campi.
Quando e come avviene l’invenzione dei campi?
Dobbiamo anzitutto sfatare un mito molto diffuso: gli insediamenti di baracche e roulotte che vediamo nelle periferie delle nostre città non sono affatto il prodotto della “cultura rom”. Sono, piuttosto, il frutto di politiche abitative che hanno di fatto costretto molte famiglie a vivere nei campi. Tali politiche nascono da quel pregiudizio “esotizzante” di cui parlavo all’inizio: cioè dall’idea secondo cui i rom sarebbero uomini e donne caratterizzati da una cultura “nomade”, e per questo vorrebbero abitare all’aria aperta, comunque non in una casa.
Negli anni Sessanta e Settanta, le principali associazioni di volontariato e gli “esperti di zingari” dell’epoca cominciarono a diffondere la cosiddetta “tesi della deculturazione”. Secondo questa lettura, la marginalità sociale dei rom e dei sinti era dovuta alla loro incapacità di adattarsi alle sfide del mondo contemporaneo: i “mestieri tradizionali” erano stati travolti dall’industrializzazione, gli stili di vita itineranti si erano rivelati incompatibili con la rigida organizzazione del lavoro propria delle società sedentarie, e le culture arcaiche dei “nomadi” non si adattavano più a un mondo dominato dalla scienza e dal progresso tecnologico. I rom erano insomma – secondo questa interpretazione – gli ultimi superstiti di una civiltà preurbana e preindustriale sconfitta dalla storia. Incapaci di stare al passo con i tempi, erano condannati a perdere la loro cultura originaria (a “deculturarsi”, appunto) e a cadere nella devianza, nella marginalità e nella delinquenza.
Per contrastare questa deriva, si diceva all’epoca, i rom dovevano essere opportunamente rieducati, civilizzati, “modernizzati”, reinseriti nella vita sociale. Da un lato, essi avevano bisogno di luoghi di accoglienza specifici e riservati unicamente a loro: in particolare, data la cultura “nomade” e itinerante che caratterizzava gran parte dei gruppi, i rom dovevano essere ospitati in campi e aree attrezzate, non in vere e proprie case. Dall’altro lato, in questi “campi” andavano promosse azioni educative che favorissero l’inserimento sociale: i rom dovevano mandare i figli a scuola, seguire corsi di formazione professionale, e soprattutto “abituarsi alle regole” della società sedentaria (rispetto di tempi e orari, disciplina sul lavoro, pagamento regolare di bollette e utenze ecc.).
Sin dall’inizio i “campi nomadi” hanno avuto questa duplice caratteristica: erano pensati come spazi dove i rom potevano vivere secondo le loro (presunte) norme culturali, ma erano di fatto luoghi di “rieducazione”, cioè di disciplinamento sociale e di controllo. Da sempre gli insediamenti di rom e sinti hanno dovuto subire le occhiute attenzioni di assistenti sociali, funzionari comunali, educatori, poliziotti, magistrati minorili. I campi – e intendo dire quelli “ufficiali”, autorizzati o costruiti dai Comuni – sono stati e sono tuttora delle strutture correzionali, delle istituzioni disciplinari e “rieducative”. E non si tratta di un problema solo italiano: è famosa una vignetta francese, in cui un rom si lamenta dicendo “il mio campo è invaso dai topi”, e il suo interlocutore risponde sconsolato “beato te, il mio è invaso dagli assistenti sociali”…
Come si sono evolute negli ultimi decenni, nel nostro Paese, le politiche rivolte ai rom?
Se vogliamo tracciare per sommi capi una storia delle politiche rivolte ai rom, il primo punto da mettere in rilievo è la diffusione dei campi nomadi: negli anni Novanta e nei primi anni Duemila si moltiplicano gli insediamenti “regolari” – cioè costruiti dalle amministrazioni comunali – così come quelli cosiddetti “abusivi”, non autorizzati né voluti dalle istituzioni. Questo fenomeno è dovuto soprattutto al fatto che in Italia sono mancate per decenni adeguate politiche di accoglienza per gli immigrati, i profughi e i rifugiati: così, quando cominciano ad arrivare i rom jugoslavi in fuga dalla guerra, non vi sono luoghi dove ospitarli. Lo stesso problema si verifica quando arrivano i rom kosovari, anch’essi profughi di un sanguinoso conflitto armato, e poi i rom rumeni, che invece arrivano soprattutto perché attratti dalle opportunità di lavoro.
In mancanza di luoghi di accoglienza, i rom migranti vengono sistemati nei campi nomadi già esistenti, o in quelli di nuova costruzione. In questo modo, il “campo” diventa il luogo principale, e per certi aspetti l’unico, dove accogliere tutti coloro che giungono dall’estero, e che si identificano (o sono identificati) come rom.
Poi, attorno alla seconda metà degli anni Duemila, il clima politico si fa più cupo: arrivano anche in Italia le politiche cosiddette “securitarie”, che vedono negli immigrati stranieri, e nelle fasce più povere della stessa popolazione italiana, un pericolo per la “sicurezza” dei cittadini. Sono gli anni delle ordinanze comunali contro i lavavetri, contro i clochard, contro i senza fissa dimora che dormono nelle stazioni o che si lavano alle fontane pubbliche: una vera e propria “guerra ai poveri”, voluta e promossa per contrastare una presunta, ma in realtà mai esistita, “guerra tra poveri”. Le politiche securitarie travolgono anche i rom e i sinti: tra gli amministratori locali si diffondono le pratiche degli sgomberi, delle espulsioni, delle “ruspe” contro le baracche… È un clima di forte ostilità contro gli “zingari”, che culmina addirittura nella dichiarazione dello “stato di emergenza” nel 2008: di fatto, la presenza dei rom e dei sinti viene equiparata a una calamità naturale, come se fosse un terremoto, un’inondazione, un’eruzione vulcanica…
Per riassumere, schematicamente, potremmo dire che le politiche sui rom e sui sinti si sono mosse lungo due direttrici: la costruzione di nuovi campi, e la diffusione degli sgomberi. Sono state politiche disastrose, che hanno alimentato marginalità e sofferenze.
Quali prospettive per i rom in Italia?
Negli ultimi anni le politiche securitarie non hanno cessato di esistere, ma si sono rivolte ad altri bersagli, in particolare ai richiedenti asilo e ai rifugiati africani che sbarcano sulle coste meridionali del paese: i rom sembrano oggi meno “appetibili” per le forze politiche che cercano di costruire le proprie fortune elettorali sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico. Al contempo, si sono pressoché esauriti i flussi migratori dei rom stranieri. Molti rom bosniaci, macedoni, kosovari o rumeni sono tornati ai loro paesi, o hanno intrapreso nuovi percorsi migratori in altre aree dell’Unione Europea. Gli ultimi dati ci dicono che gli abitanti dei campi (sia dei campi “ufficiali” che di quelli non autorizzati e informali) sono sensibilmente diminuiti.
Non sarebbe difficile, in questo clima meno “infuocato”, promuovere anche a livello locale delle politiche efficaci di inserimento sociale e di fuoriuscita dalla marginalità. Manca ancora, purtroppo, una precisa volontà politica in questo senso.
Sergio Bontempelli, operatore legale ed esperto di immigrazione, è stato tra i fondatori della ONG OsservAzione e ha pubblicato numerose ricerche su rom e sinti