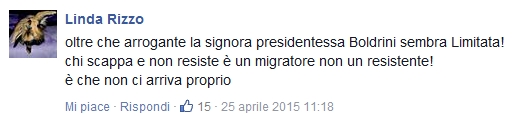Originariamente pubblicato sul sito di Adif – Associazione Diritti e Frontiere
Originariamente pubblicato sul sito di Adif – Associazione Diritti e Frontiere
È uno degli argomenti contro i profughi che sbarcano sulle coste: “loro” fuggono, “noi italiani” restammo a combattere. Ma le cose sono davvero così semplici?
Da qualche tempo, a proposito dei richiedenti asilo e dei rifugiati che sbarcano sulle nostre coste, circola un discorso di senso comune, che si potrebbe grosso modo riassumere così: «i profughi scappano dalle dittature e dai conflitti… invece noi italiani, in tempo di guerra, non abbandonammo il paese, e restammo a combattere. Per questo ci fu la Resistenza, e per questo l’Italia fu liberata».
Al momento, questa argomentazione non sembra ancora avere il suo corifeo, cioè il giornalista, il politico o lo storico (più o meno “embedded”) disponibile a farla propria e a divulgarla. Sta però circolando molto su internet, nei commenti degli utenti ai fatti di cronaca e nei post sulle pagine private di Facebook.
Un esempio su tutti: il 25 Aprile scorso, quando la Presidente della Camera Laura Boldrini paragonò i migranti di oggi ai partigiani di ieri, furono in tanti a rispondere – per l’appunto – che «i partigiani combattevano, non scappavano». Ecco alcuni commenti postati su un articolo dell’Huffington Post (se il link non si apre leggilo qui):
Certo, può far sorridere il fatto che questa esaltazione della Resistenza provenga proprio dagli utenti dei social network, che di norma scrivono comodamente seduti in salotto, al riparo delle proprie tastiere, comunque lontani dai pericoli della vita reale. C’è da scommettere che molti di loro reagirebbero alle torture nel modo descritto dal grande Massimo Troisi in Ricomincio da tre: «Per carità! A me non c’è bisogno di torturarmi. A me basta che dicevano “Guarda che se non parli, forse ti torturiamo”, e immediatamente parlavo, scrivevo, se non capivano facevo pure un disegno…».
Semplificazioni
Il punto è però un altro. È chiaro che questo discorso di senso comune non parla della Resistenza ma delle migrazioni attuali: non serve cioè ad esaltare le virtù eroiche dei partigiani di ieri (peraltro rimesse in discussione da una lunga, e sciagurata, tradizione di “revisionismo storico”), ma a costruire un’immagine negativa e svalorizzante dei profughi, dei richiedenti asilo e dei rifugiati di oggi.
Non a caso questo discorso fa leva su contrapposizioni schematiche (paura/coraggio, fuga/resistenza, codardia/eroismo), che mal si adattano ad un’analisi seria del fascismo, dell’antifascismo e della liberazione. In sede storiografica, infatti, le cose sono assai più complesse.
Partire dai dati
In primo luogo, l’affermazione secondo cui «gli italiani rimasero in Italia, non scapparono» è assai difficile da sostenere. Tra il 1931 e il 1940, i nostri connazionali che scelsero di trasferirsi all’estero furono più di 700mila [ISTAT, Sommario di Statistiche storiche dell’Italia, 1861-1865, Istat, Roma 1968, pag. 28; se il link non funziona leggi qui; rielaborazione mia]: non pochi, per un paese che all’epoca contava poco più di 40 milioni di abitanti [ISTAT, L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010, Istat, Roma 2012, cap. II, pag. 102; accedi all’intera pubblicazione sul sito dell’Istat].
Per gli anni della guerra le statistiche sono più incerte, per motivi che non è difficile intuire. Sappiamo però che nel biennio 1941-42 il numero di emigranti che decisero di tornare in Italia subì un crollo vertiginoso, passando dagli 87mila del 1939 agli appena 20mila del 1942 [ISTAT, Sommario di statistiche storiche, cit., pag. 28]. Seguendo lo schema – semplificatorio e banalizzante – di tanti commentatori seriali sui social network, dovremmo dire che gli italiani non tornarono in patria a combattere l’oppressore, ma rimasero dov’erano, all’estero…
Non basta. Se facciamo un piccolo salto temporale, e passiamo al Giugno 1945 – dunque alla fine della guerra – scopriamo che i profughi di nazionalità italiana presenti in Europa erano 300mila, e costituivano da soli l’11% dei displaced persons, cioè di tutti gli sfollati e i rifugiati presenti nel Vecchio Continente [Silvia Salvatici, Senza casa e senza paese. Profughi europei nel secondo dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2008, pag. 39].
Per farla breve: gli italiani di allora fuggirono eccome, sia per cercare fortuna altrove (oggi li chiameremmo “migranti economici”), sia come profughi, rifugiati e sfollati. Eppure, fecero la Resistenza e liberarono l’Italia. Come la mettiamo?
Fuga e conflitto: una relazione complessa
Il fatto è che, contrariamente a quanto si crede, migrazione e lotta politica all’interno di un paese non sono atteggiamenti in contrasto tra loro: partire non significa necessariamente abbandonare la propria terra, né rinunciare alla battaglia per renderla migliore. Ed è proprio la storia della Resistenza italiana a dimostrarlo.
I flussi di emigranti italiani, che avevano conosciuto una battuta d’arresto con la prima guerra mondiale, ripresero sin dagli anni Venti. Per i nuovi migranti, la decisione di trasferirsi all’estero «nasceva non solo da ristrettezze economiche patite in Italia, ma anche, e in molti casi soprattutto, dal bisogno di “cambiare aria”, di abbandonare luoghi di residenza nei quali la vita si era fatta rischiosa ed insostenibile a causa degli attacchi dello squadrismo fascista, e la possibilità stessa di conservare o trovare un’occupazione era compromessa dalle intimidazioni, dall’emarginazione sociale e dai veri e propri “bandi” con cui i fascisti, divenuti padroni del territorio, colpivano i militanti (…) della sinistra politica e sindacale» [Leonardo Rapone, Emigrazione italiana e antifascismo in esilio, in «Archivio storico dell’emigrazione italiana», IV, 2008, 1, pagg. 53-67].
Si trattava dunque di una migrazione economica, in cui però erano forti anche le motivazioni politiche: allora come oggi, la distinzione tra “immigrati” e “rifugiati” non era così facilmente tracciabile. Questi lavoratori italiani, che avevano lasciato il paese per trovar fortuna altrove, erano in molti casi ostili al regime fascista, e incontrarono i cosiddetti “fuoriusciti”, cioè i veri e propri esuli, i militanti e i dirigenti delle organizzazioni antifasciste costretti a lasciare l’Italia.
Fu proprio l’incontro e lo scambio tra questi due soggetti (i migranti e gli esuli) a favorire la nascita – o per meglio dire la rinascita – dei partiti democratici, socialisti e comunisti all’estero. In alcuni paesi europei – e in particolare in Francia – queste formazioni politiche si ricostituirono attingendo all’enorme serbatoio degli emigranti italiani. Questi avevano nel frattempo partecipato alla vita politica e sindacale dei paesi di destinazione: portavano quindi un bagaglio di esperienze che non sarebbe stato possibile accumulare in Italia, dove ogni dialettica politica era stata cancellata.
Non ci sarebbe stata la Resistenza senza i partiti antifascisti, che proprio all’estero – tra i rifugiati e gli emigranti italiani – si erano ricostituiti e rafforzati. O, per meglio dire, la Resistenza fu il risultato del lavoro coraggioso e instancabile sia di chi era rimasto in Italia, sia di chi si trovava all’estero. Senza questo fecondo scambio, senza questa interazione transnazionale, i partigiani probabilmente non sarebbero esistiti, o avrebbero perso la loro battaglia.
Il ruolo delle diaspore
Peraltro, questo discorso non riguarda solo l’Italia. Sono moltissimi gli esempi di trasformazioni politiche, o di vere e proprie rivoluzioni, in cui i lavoratori emigrati all’estero, così come i rifugiati o gli esuli fuggiti dal proprio paese, hanno giocato un ruolo da protagonisti.
Il caso più noto è probabilmente quello dell’India: il mahatma Gandhi elaborò la sua strategia non-violenta, e definì i concetti più importanti del suo pensiero (satyagraha, resistenza passiva, disobbedienza civile), difendendo gli indiani emigrati in Sudafrica. Senza l’esperienza sudafricana, senza le lotte dei coolies e dei lavoratori migranti, l’intera vicenda della decolonizzazione indiana sarebbe impensabile.
Un’altra decolonizzazione, quella algerina, è maturata grazie all’interscambio incessante tra le lotte all’interno del paese, e le mobilitazioni degli algerini emigrati in Francia [si veda Benjamin Stora, Avant la deuxième génération: le militantisme algérien en France (1926-1954), in «Revue européenne des migrations internationales», vol. 1, n. 2, Dicembre 1985, numero monografico su «Générations nouvelles», pagg. 69-93].
La letteratura scientifica parla oggi del “ruolo delle diaspore”, intese come collettività di migranti o di rifugiati che mantengono un rapporto culturale, sociale, a volte persino economico (si pensi alle rimesse, cioè ai soldi che gli immigrati mandano alle famiglie) con i paesi di origine [si veda Andrea Stocchiero (a cura di), Le diaspore africane tra due continenti, CESPI, Roma 2008]. Spesso sono proprio le diaspore a creare collegamenti preziosi con altre realtà internazionali, a fornire informazioni e notizie (quando la censura ne impedisce la circolazione all’interno dei confini di uno Stato), a volte persino a organizzare – dall’estero – movimenti di protesta e mobilitazioni sociali.
In altre parole, migrazione non è sempre sinonimo di fuga, non vuol dire sottrarsi al compito di cambiare – in meglio – il proprio paese. Andarsene significa spesso, più semplicemente, “votare con i piedi”, dunque contribuire in altro modo a cambiare il mondo in cui si vive. Anche per questo, i profughi e i migranti andrebbero ascoltati e capiti: avremmo tanto da imparare, se non fossimo incollati alle tastiere dei nostri smartphone, a discettare di Resistenza e antifascismo…
Sergio Bontempelli
5 Novembre 2015